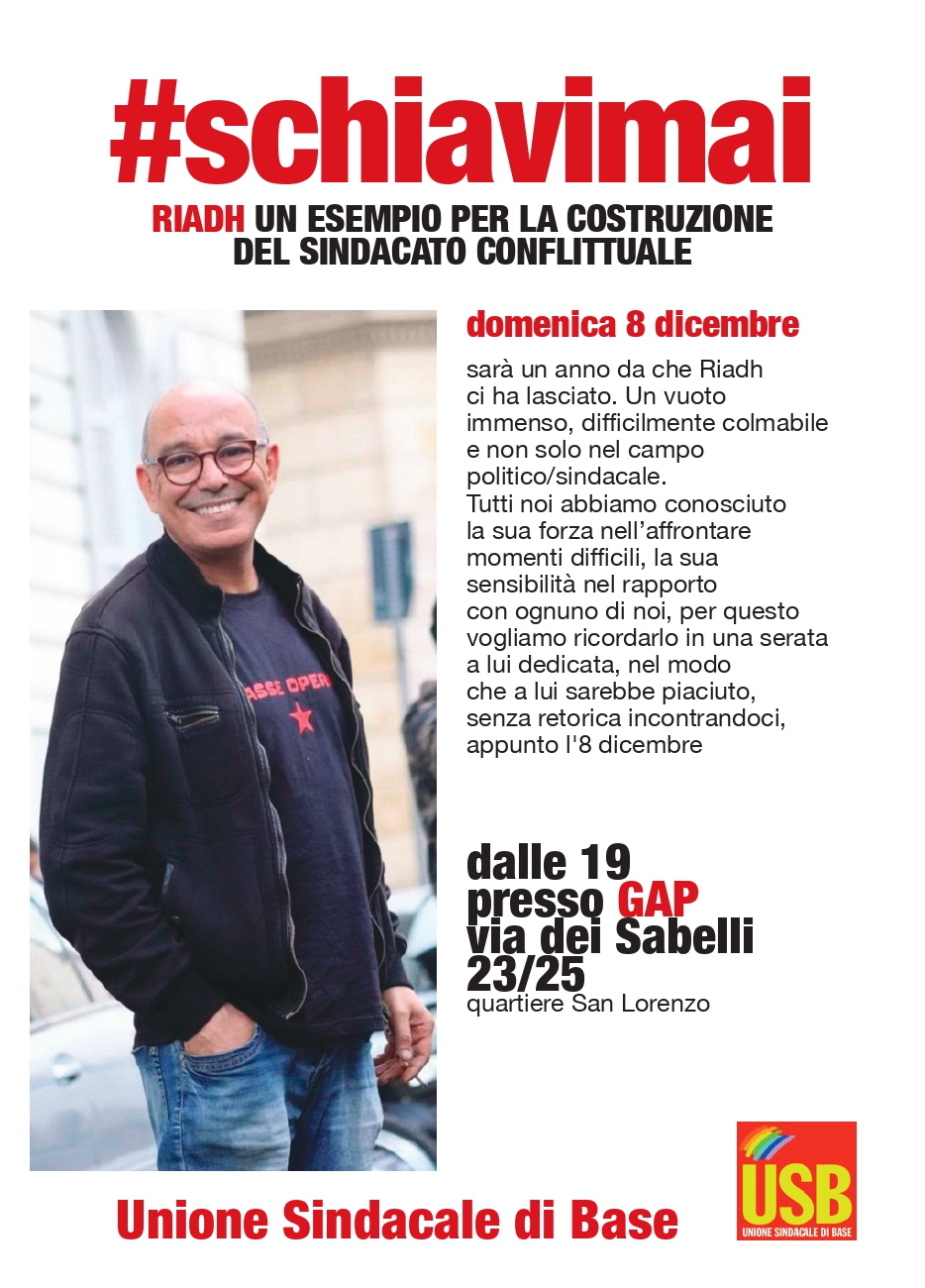La violenza di genere continua ad essere quel comune denominatore su cui si iscrivono le biografie di almeno un terzo della donne italiane e le sue estreme conseguenze: il femminicidio (123 nel 2016, ad oggi), l’orrore su cui media ed istituzioni pubbliche volgono strumentalmente il loro sguardo distratto e discontinuo. E’ l’espressione più estrema di una discriminazione che la società di fatto condona, essendo essa stessa influenzata da una cultura patriarcale e da rapporti di potere che subordinano le donne agli uomini.
Su questa asimmetria di potere tra i generi che condiziona ogni aspetto della vita quotidiana delle donne - dentro e fuori le mura domestiche - agiscono una pluralità di fattori. Tra questi, la scelta politica delle istituzioni pubbliche di rimuovere o meno le condizioni discriminanti è tutt’altro che secondaria. Il disinvestimento e il tentativo di rendere luoghi neutri i centri antiviolenza, l’obiezione di coscienza dilagante nei consultori che impedisce la libera scelta alla maternità, sono solo esempi di scelte politiche gravissime che sottendono una visione di una questione sociale derubricata a questione individuale.
In questo quadro, Welfare e Lavoro entrano a pieno titolo tra quei fattori che possono ostacolare o meno l’autodeterminazione delle donne, liberarle o meno dello stereotipo che su di esse incombe e che le intrappola “naturalmente” nelle mura domestiche, nella cura incondizionata dei propri figli, anziani e disabili.
Ma in un sistema sociale come il nostro che ha fatto proprio un modello di sviluppo che produce disuguaglianze sociali, economiche e di accesso ai diritti, quelle di genere rischiano di rimanere sepolte in un’agenda politica eterodiretta dalla Troika e decisamente orientata a smantellare il welfare pubblico da un lato, e massimizzare i profitti attraverso l’abbassamento della qualità del lavoro, dei salari, della sicurezza, dall’altro.
Il lavoro femminile, così come si è storicamente determinato: precario, ad intermittenza, demansionato e sottopagato, diviene così lo standard cui condannare tutti i lavoratori ed in primis, i giovani. La crisi economica e le fallimentari politiche di austerità messe in atto per fronteggiarla, non solo non hanno frenato l’emorragia di milioni di posti di lavoro ma hanno ridisegnato i contorni delle dinamiche del mercato del lavoro rendendo tutti più insicuri, instabili e soprattutto più tolleranti rispetto l’erosione dei diritti conquistati. I recenti dati diramati da Eurofound vanno in questa direzione: con la crisi abbiano perso i posti di lavoro cui corrispondevano salari medio bassi e medio alti . Quelli recuperati - solo in parte - si collocano prevalentemente nella fascia più bassa dei salari e dunque, in quei settori dei servizi dove si addensano le condizioni di lavoro peggiori. Nulla di nuovo all’orizzonte, visto che anche il Rapporto 2016 dell’Istat segnala come dal 2008 al 2015 le professioni che sono cresciute sono quelle non qualificate (21%) e quelle esecutive (9,9%). Di contro, le professioni qualificate e tecniche sono scese a -7,7% e gli artigiani e operai a -16,5 %.
E nonostante il lavoro sia “cattivo lavoro” per tutti, le condizioni lavorative delle donne continuano ad essere segnate da gender gap, ossia da differenziali, distanze, discriminazioni, sia nell’accesso al mercato del lavoro, sia nella qualità della permanenza. Con un sconsolante tasso di occupazione del 57,7% l’occupazione femminile arriva appena al 48,2% a fronte di quella maschile del 66,9%. Cresce invece la disoccupazione 11,7% (più 98 mila in un anno) e stavolta è quella femminile 12,8% ad attestarsi al di sopra del dato generale, mentre il tasso di disoccupazione maschile è di 10,8%.
C’è chi si rallegra del fatto che finalmente le donne “cercano attivamente lavoro” poiché diminuiscono quelle che il lavoro non lo cercano più. Magra consolazione, visto che il tutto si traduce in qualche punto percentuale in più di disoccupazione e qualcuno in meno nel tasso di inattività femminile. Già, perché le donne vogliono esser soggetto attivo nel mercato del lavoro e ne sono prova gli alti livelli di istruzione e i migliori risultati conseguiti negli studi. Ciononostante, la loro mancata partecipazione al lavoro continua ad essere un dato imbarazzante per il nostro Paese con quel 26,8% contro il 19% di quello maschile.
E quando le donne entrano nel mercato del lavoro, pagano la scelta – sempre più involontaria - del part-time che le esporrà a rischi di povertà dettati dalle basse pensioni. La diffusione del lavoro part time – specie quello involontario - cresciuto ininterrottamente durante la crisi (18,3%) pur incidendo su entrambi i generi, lo ha fatto in modo differenziato : 32% sulla componente femminile, l’8% su quella maschile. Troppe le ore di vita dedicate al lavoro non retribuito e troppo poche le ore di lavoro retribuite.
Ma ad acuire le distanze di genere nel mercato del lavoro ci pensano anche le nuove forme di precariato più estremo, quello incarnato dai voucher, nuova forma di schiavitù istituzionalizzata. Il 51,5% dei destinatari è donna. Sul fronte del differenziale salariale a parità di mansione, le donne continuano a percepire il 10,9% in meno degli uomini; differenziale che cresce inesorabilmente al crescere della gerarchia professionale. Ma sul differenziale retributivo grezzo (6,1%) incide anche il settore di impiego, al punto che mentre nel pubblico si attesta sul 5,4% si triplica nel privato: 15,7%.
Un differenziale che pesa a tal punto che dalle ore 14.58 del prossimo 9 dicembre le donne italiane lavorano gratis!
Gli esiti del divario retributivo e della discontinuità contributiva impattano sul reddito femminile lungo tutto l’arco di vita: più precarie da giovani, più povere in vecchiaia. Basta osservare i dati sull’importo medio pensionistico non superiore alle 500 euro mensili , per scoprire che dei 2 milioni ed oltre di pensionati che vive in condizioni di povertà assoluta severa, il 57,1% è donna.
Tagliare e privatizzare i servizi pubblici ha un duplice impatto negativo sulle donne: da un lato le costringe a farsi carico di un welfare familistico, disincentivando la loro presenza sul mercato del lavoro e dall’altro, indebolendo quel settore, il pubblico impiego, che ha rappresentato lo spazio entro cui agire la propria emancipazione nell’impiego. Non è casuale che la componente femminile costituisca il 55,7% dei lavoratori pubblici con un ruolo chiave giocato dalla Scuola, dalla Sanità e dalle Regioni ed Enti territoriali. I più alti livelli di istruzione nel settore si rilevano proprio tra le donne (31% di laureate donne contro il 21 % di laureati uomini).
In sintesi, l’assenza o la presenza di un lavoro dequalificato e/o precario, la mancanza di politiche di protezione sociale, sul reddito e sulla casa, lo smantellamento del welfare e dei servizi pubblici se non sono direttamente responsabili delle violenze in sé, lo sono sicuramente nell’impossibilità di rendere praticabili percorsi di affrancamento da essa e nel riperpetuare una cultura della donna come unica responsabile del lavoro domestico e di cura. Le risposte al fenomeno strutturale della violenza di genere non possono essere emergenziali e repressive.
Rivendichiamo il diritto a servizi pubblici accessibili, al reddito sociale, a casa, lavoro e parità salariale; all’educazione scolastica, alle strutture sanitarie – a cominciare da consultori liberi da obiettori; alla formazione di operatori sociali, sanitari e del diritto.
Vogliamo il riconoscimento ed il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che denunciano le violenze.
Le politiche di austerità, imposte da un governo asservito ai dettami dell’Unione Europea, rappresentano la negazione di quanto minimamente necessario al contrasto della violenza di genere: il 26 novembre gridiamolo forte e chiaro!
Aderente
alla FSM