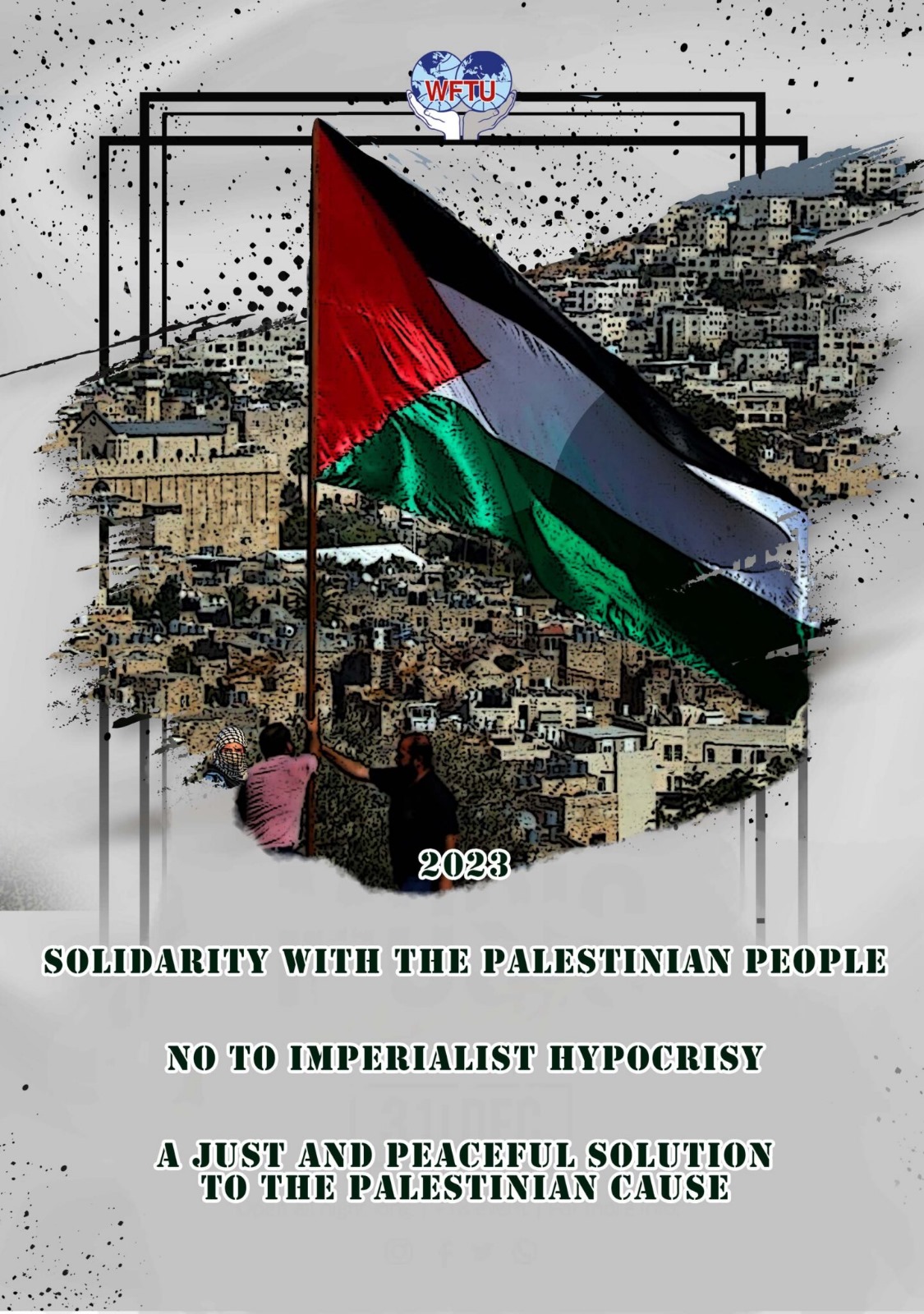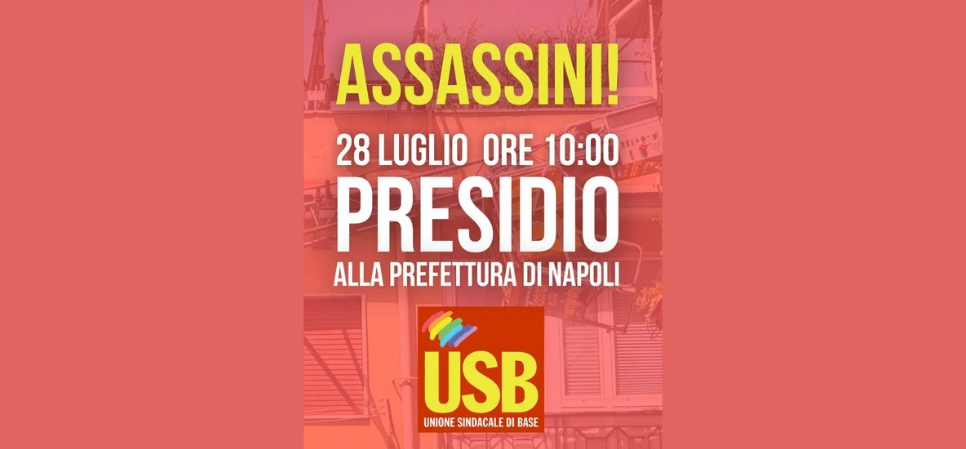Opportunità e rischi associati all’innovazione tecnologica nel settore della Logistica e Trasporto Merci
Contesto e tendenze
L’ultimo decennio, che ha visto il consistente sviluppo del settore della Logistica, è stato contemporaneamente attraversato da un crescente processo di digitalizzazione ed
innovazione tecnologica che ha contribuito a modificare radicalmente l’economia ed il mercato del lavoro a livello globale.
L’anno 2020 in particolare, durante il periodo della pandemia, ha messo in pratica, pur in maniera spesso disorganizzata e non strutturale, i primi tentativi di approccio innovativo alla giornata lavorativa. Ciò ha comportato un incremento, per necessità, dell’utilizzo dello smart working, facendo assurgere, inoltre, al ruolo di attività essenziale tutto il comparto della logistica. L’esplosione dell e-commerce e la necessità di far circolare beni di ogni genere nel contesto di immobilità forzata, ha creato una contraddizione netta tra la ricerca di forme di lavoro più agile e l’incremento di figure e modelli tradizionali come spedizionieri ed addetti logistici a tutti i livelli.
*
Impatti su occupazione, produttività e sicurezza
L’introduzione delle nuove tecnologie continua a comportare un’ampia e progressiva
ristrutturazione del mondo del lavoro, sia in termini di modelli organizzativi che di forme occupazionali, generando nuove opportunità, ma anche rischi, che ricadono principalmente sulla forza lavoro e, in alcuni casi, ne compromettono la prospettiva di continuità occupazionale a lungo termine, tanto per la soppressione delle tradizionali figure lavorative, tanto per l’insorgenza di problematiche legate a nuove forme di disagio psico fisico.
Infatti, se da un lato la digitalizzazione facilita l’emergere di nuovi lavori e sicuramente sta contribuendo ad un miglioramento a vantaggio dell’efficienza produttiva, dall’altro sta alimentando rischi e preoccupazioni riguardo il divario sociale e tecnologico tra generazioni, la sicurezza sul lavoro, in difetto di interventi pubblici, sociali ed economici atti a favorire il ricambio generazionale, oltre a inevitabili disuguaglianze economiche derivanti dagli stessi presupposti.
Il mercato del lavoro quindi sta vivendo una fase storica di cambiamenti senza precedenti in cui l’innovazione tecnologica riformula necessità e strutture organizzative, comportando profonde modifiche anche nella domanda e nella ricerca di competenze professionali.
Mentre i processi di automazione trasformano i settori tradizionali, riducendo gradualmente la necessità di manodopera a meri compiti ripetitivi dettati da algoritmi, le nuove tecnologie non sono percepite come un supporto utile a ridurre la fatica ma solo all’incremento della redditività e della produttività. Ciò influenza in maniera indirettaanche la redistribuzione della forza lavoro, creando sacche di sfruttamento a termine di lavoratori destinati a un transito sempre più rapido nei singoli contesti lavorativi, senza supporti necessari per la ricollocazione nel mercato del lavoro.
Un dato ricorrente degli effetti dell’innovazione tecnologica è il significativo aumento della produttività e della redditività aziendale tanto nei settori emergenti che in quelli tradizionali interessati dalla riorganizzazione produttiva basata sull’incremento delle attività digitali. Tale incremento però costituisce anche un primo campanello d’allarme per quanto riguarda le condizioni delle componenti operaie, sempre più schiacciate dagli impatti di quella che viene percepita come una sorta di “dittatura algoritmica” e sempre più esposte a stress, malattie professionali nuove e fenomeni di burnout.
Le analisi sugli impatti relativi a occupazione, produttività e sicurezza, pur variando sostanzialmente in base al settore merceologico, evidenziano in ogni caso come l’automazione tenda a incanalare il mercato del lavoro polarizzandolo, con il rischio di possibili esuberi occupazionali in settori ad alta intensità di manodopera con scarse conoscenze tecnologiche. Di contro, come premesso, l’impatto sulla produttività tende a registrare trend positivi anche in prospettiva futura, da cui però si sviluppa la necessità di interrogarsi e trovare opportuni bilanciamenti sulle ripercussioni a tutti i livelli, economici e sociali, se tale aumento non verrà accompagnato da una equa redistribuzione dei benefici.
In questo scenario è opportuno che i governi, le istituzioni, le organizzazioni sindacali e datoriali, contribuiscano a sviluppare una serie di proposte che prevedano politiche redistributive e di welfare in grado di compensare gli squilibri prodotti dalla trasformazione tecnologica, in termini di eliminazione di figure professionali divenute obsolete e di de-professionalizzazione delle attività attuali, come ad esempio la figura del magazziniere rispetto all’impatto che la robotica sta già avendo nella trasformazione delle attività da eccessivamente dinamiche a ripetitive, statiche e di basso profilo professionale.
In sintesi possiamo affermare che i nuovi paradigmi dell’economia tecnologicamente avanzata offrono opportunità nuove ma al tempo stesso accentuano le sfide legate alla necessità di una regolamentazione che non sia a senso unico, cioè che non favorisca solamente il profitto, ma tenga conto della protezione, della sostenibilità economica a lungo termine e del mantenimento dei diritti dei lavoratori.
Tali previsioni si inseriscono in uno scenario, caratterizzato dall’utilizzo di quel sistema di appalti e subappalti deflagrato sotto le indagini delle Procure di tutta Italia, che si presenta già flessibile e precario e che tende a richiedere l’inserimento di ulteriori elementi di flessibilità, oraria e contrattuale, con una nuova generazione di lavoratori esposta a rischi economici significativi, senza il supporto di reti di vera ed efficace sicurezza sociale.
*
Rischi della “dittatura algoritmica”
Un aspetto illuminante della situazione che investe il settore è quello costituito dall’apparente processo di democratizzazione del lavoro offerto dalle piattaforme digitali, che promettono a chiunque un accesso facile alla domanda ed alle opportunità di guadagno con poche barriere di accesso (Amazon o le aziende del Food Delivery), ma che in realtà si rivelano come occupazioni a breve termine e spesso con retribuzioni legate alla capacità di iperproduttività, indirizzata da quella che abbiamo già denominato “dittatura algoritmica”. Questo controllo, apparentemente fluido ed invisibile, rappresenta in realtà una nuova forma di subordinazione descritta come processo di autonomia. I lavoratori sono in realtà soggetti a un sistema in cui tanto la proposta occupazionale che il mantenimento della propria posizione, sono gestiti e dipendono da meccanismi algoritmici. Il prezzo da pagare è una crescente precarizzazione del lavoro dovuta all’esigenza di flessibilità, mobilità e produttività, senza strumenti sociali di sicurezza a supporto.
Contrattazione di secondo livello e innovazione tecnologica
L’automazione, il controllo digitale, la possibilità di indicizzare ordini di servizio e valutazioni delle performance, sta anche comportando nuove aberrazioni del sistema di valutazione e valorizzazione dell’impegno e della fatica in ambito lavorativo. Una delle conseguenze della digitalizzazione infatti è stata quella di individuare formule incentivanti per raddoppiare la produzione a costi contenuti.
In un contesto in cui gli aumenti strutturali delle retribuzioni, anche al netto dei rinnovi contrattuali, sono lontani dal far recuperare la perdita progressiva del potere d’acquisto, le uniche forme di incentivo a livello economico sono demandate alla contrattazione di secondo livello. Non a caso gli unici interventi negli ultimi anni sono legati a misure come la detassazione dei Premi di Risultato, indirizzata, normativamente e fiscalmente, alla richiesta di aumento della produttività, singola o collettiva, che sottintende un aumento della fatica, aggravando la condizione lavorativa e lo stress correlato, con beneficio esclusivamente datoriale.
La contrattazione di secondo livello, nell’ambito dei processi di innovazione tecnologica, invece di produrre elementi di innovazione si è quindi impantanata sulla necessità di aumentare i ricavi, contribuendo alla diminuzione della domanda di forza lavoro per sfruttare quella già in essere, in cambio di benefit detassati; un controsenso dal punto di vista sia economico che sociale.
Impatti psicologici e psicosociali
Un altro aspetto riguarda l'incidenza che i mutamenti avranno a livello psicofisico in una condizione nuova che, mentre potenzialmente potrà minimizzare i pericoli fisici in determinati ambienti lavorativi altamente robotizzati, in altri come ad esempio il personale viaggiante del trasporto merci, rischia di aumentarli a causa della richiesta di maggior velocità dovuta alla necessità di incentivare la rapidità di consegna e sostenere gli ordini impartiti dalla dittatura algoritmica.
Tra le trasformazioni più incisive vi è l’adozione, da parte datoriale, di sistemi informatici basati su algoritmi, per la gestione dei rapporti con il personale, per l’organizzazione stessa del lavoro e per la valutazione delle performance. Sono sempre più frequenti gli episodi di “discriminazione algoritmica”, che, a dispetto anche della percezione dei lavoratori, si configura come discriminazione vera e propria, dal momento in cui il datore di lavoro utilizza consapevolmente l’analisi dei dati per celare un effetto discriminatorio diretto, di fatto annullando qualsiasi valutazione meritocratica, ma affidandosi ad analisi il più delle volte incomprensibili agli stessi operatori del settore.
Sicurezza e condizioni lavorative
Nonostante il processo di digitalizzazione in corso, come ampiamente previsto, anche nel settore della logistica non è diminuita la fatica, in un'attività che non conosce soste, per servire un flusso costante ed incessante di merci.
Sono evidenti i rischi emergenti per la salute e sicurezza. I corrieri ed i camionisti, oltre ai rischi ergonomici legati alla guida ed alla movimentazione dei carichi, sono esposti a nuovi e più incidenti rischi a causa della richiesta di prestazioni sempre più intense.
Preoccupanti sono i rischi per la sicurezza stradale dovuti allo stress, alla velocità, all'astensione dalle pause per portare a termine carichi di lavoro sempre più pesanti in un settore ossessionato dalla velocità.
In un impianto di logistica classico, con tecnologia non avanzata, il rischio a livello fisico è tradizionalmente legato alla movimentazione dei carichi e al transito dei mezzi di trasporto o all'eventualità di essere colpiti da un oggetto che cade da uno scaffale o da un muletto. Negli stabilimenti a più elevata robotizzazione tali rischi tendono a svanire, ma ne insorgono di nuovi: gli operatori moderni non si muovono nell’impianto, ma stazionano in una postazione di fronte alla quale transitano i robot. I nuovi pickeristi operano in postazione fissa svolgendo lo stesso compito in maniera ripetitiva. Questi nuovi ambienti lavorativi fanno emergere un nuovo elemento di rischio sempre più frequente: lo stress psicosociale che si sostituisce a quello fisico.
L'esponenziale crescita dei rischi di natura psico-sociale e di stress da lavoro correlato è certificata da numerose analisi e indagini che affrontano la trasformazione digitale del lavoro evidenziando la correlazione tra digitalizzazione e sovraccarico cognitivo, incertezza lavorativa, mancanza di fiducia ed isolamento.
Questo evidenzia come la progettazione degli interventi di automazione e utilizzo delle nuove tecnologie non siano prioritariamente orientati al miglioramento della condizione lavorativa, ma a quella dei risultati economici, dai quali scaturiscono effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Proposte e necessità di intervento
I rischi derivanti dalla tecnologizzazione riguardano il pericolo di disoccupazione tecnologica, il peggioramento della qualità e delle condizioni lavorative, l’incremento potenziale di disuguaglianze economiche, l’emergere di nuovi rischi per la salute e sicurezza e nuove forme di stress e precarietà.
Per evitare che gli effetti dell’innovazione tecnologica siano positivi per le aziende, ma negativi per i lavoratori, servirà innanzitutto un sistema di protezione sociale ampio ed inclusivo, che si occupi di bilanciare la flessibilità del mercato, garantendo un reale supporto economico ai potenziali disoccupati tecnologici, cercando di limitare i periodi di disoccupazione attraverso formazione e interazione con il mercato del lavoro.
Un’attenzione particolare dovrà essere indirizzata all’utilizzo di queste tecnologie anche a supporto delle richieste e delle esigenze dei lavoratori, sia in termini di riduzione dell’orario a parità di salario, sia in termini di tutela della salute e del bilanciamento tra tempi di vita e lavoro. La logistica ed il trasporto merci occupano ormai un numero di addetti maggiore di quello di altri settori tradizionali ed il comparto esprime una tendenza alla crescita, tuttavia non sappiamo quanto la rivoluzione digitale e le innovazioni tecnologiche trasformeranno il settore e se saranno in grado di mantenerne l’attuale trend occupazionale.
Al momento purtroppo dobbiamo registrare che tale innovazione tecnologica sta condizionando in maniera particolarmente allarmante alcuni aspetti come l'aumento dei carichi di lavoro per il personale viaggiante , la riduzione dell'offerta lavorativa per i lavoratori dell' handling, facchini e magazzinieri, la riduzione dei nastro lavorativo con conseguente perdita occupazionale, un eccesso di flessibilità consentito anche dai recenti rinnovi contrattuali oltre a nuove patologie.
Le nuove tecnologie rischiano di rivelarsi non solo come un sostituto meccanico dell'uomo ma addirittura come un'alternativa al suo apporto intellettuale. Di fronte alla robotizzazione uno dei rischi diventa quindi la potenziale banalizzazione dell'azione umana e la sua completa de-professionalizzazione.
Se tutto ciò non sarà supportato da politiche di sostegno industriale, sociale ed economico si rischierà di compromettere tutti i potenziali vantaggi conseguenti alla transizione digitale, comportando inevitabilmente l'insorgenza di situazioni conflittuali per chi vedrà minata la propria stabilità ed il proprio futuro lavorativo da un nemico virtuale, ma rapido ed aggressivo.
CNEL - INDAGINE CONOSCITIVA SETTORE LOGISTICA
Considerazioni di USB Logistica sulle Bozze di Articolato Normativo proposte da parte datoriale
CONTROLLI A DISTANZA
- Quanto alle modifiche dell’art.4 l.300/1970 pg.11 e ss.
- Quanto alle modiche sostanziali.
Appare evidente che il tentativo è quello di liberalizzare l’utilizzo indiscriminato di ogni di tipo di apparecchiatura dalla quale possa derivare anche il controllo della prestazione.
Si rileva che, nel mutato contesto tecnologico, vi sono molteplici apparecchiature che, pur avendo una funzione dal punto di vista tecnico od organizzativo, possono essere utilizzate per un controllo pervasivo della prestazione del lavoratore.
Si pensi ad esempio:
- Ai dispositivi terminali (c.d. palmari) collegati a software gestionali, ad esempio nell’organizzazione di percorsi di consegna, che hanno contezza al millimetro, degli orari ed indirizzi frequentati dal lavoratore.
E’ del tutto evidente che liberalizzare, come vuole la riforma, l’uso indiscriminato di tali dispositivi, consente al datore di lavoro di tracciare indiscriminatamente le performance dei singoli lavoratori, con funzione di controllo della prestazione.
Sull’argomento si ritiene che, in alternativa:
-
- I dispositivi terminali non possano rilevare i dati relativi all’orario esatto di consegna della merce, ma al massimo possano tracciare i percorsi effettuati;
- I relativi dati, laddove acquisiti, debbano essere necessariamente cancellati entro un periodo congruo (24/48 ore).
- Alle telecamere:
Si ritiene che l’attuale assetto normativo sia rispettoso dei contrapposti interessi e che dunque le telecamere possano essere installate a soli fine difensivi, laddove non sia contemporaneamente consentito un indiscriminato controllo della prestazione.
Per quanto riguarda il “fondato sospetto” della commissione di atti illeciti quale presupposto imprescindibile per l’installazione ed effettuazione d’indagini non si condivide sia necessaria alcuna modifica dell’assetto normativo – giurisprudenziale attuale.
Infatti, ragionare diversamente consentirebbe di nuovo l’avvio di controlli in maniera indiscriminata ed oltremodo pervasiva.
- Ai dispositivi satellitari:
Si ritiene quanto sopra riportato sui dispositivi palmari.
Si condividono le statuizioni del Garante della privacy, provvedimento 7 del 16.1.25 secondo cui i dispositivi satellitari sono da ritenersi vietati dall’ordinamento laddove consentano un monitoraggio permanente della prestazione.
*
-
- Quanto alle riforme procedurali proposte.
Poiché gli organici della ITL non sono attrezzati per garantire termini stringenti il “silenzio assenso” è palesemente sbilanciato in favore delle imprese.
Peraltro, l’autorizzazione di cui all’art.4 l.300/1970 ha ad oggetto meri diritti patrimoniali, i quali non necessitano di alcuna tutela preferenziale o d’urgenza.
Sarebbe invece importante stabilire il necessario coinvolgimento delle Rsu/rsa dei sindacati maggiormente rappresentativi presso la singola unità produttiva, in ambo le procedure (provinciale/nazionale) previste dall’art.4.
Infatti, non vi è alcun indice migliore del grado di rappresentatività di una o.s. che l’effettivo numero di iscritti presso la singola unità interessata alla procedura.
Testo proposto.
- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, a condizione che da tale utilizzo non possa derivare un indiscriminato controllo della prestazione lavorativa. Il confronto dovrà estendersi alle associazioni sindacali che contino con oltre il 10% degli iscritti nella singola unità produttiva. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella procedura il confronto dovrà avvenire anche con le oo.ss che contino con oltre il 10% degli iscritti nella singola unità produttiva. In ogni caso, In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, salvo che da questi possa derivare un controllo indiscriminato della prestazione e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*
-
- APPALTO (pg.18 e ss).
Il mutato contesto tecnologico ha evidenziato il diffuso utilizzo dell’istituto dell’appalto non genuino, principalmente nel settore logistica.
Tale diffusione appare connaturale al modus operandi di un sempre più crescente numero di operatori, che si avvale sistematicamente di evoluti software aziendali di proprietà (e controllo) da parte dal committente.
L’intento è quello di toccare due aspetti: blindare a priori la genuinità e consentire a talune imprese di liberarsi del vincolo di solidarietà di cui all’art.29 d. lgs 276/2003.
Siamo contrari ad entrambe le proposte.
In controtendenza, riteniamo che l’utilizzo di tecnologie di un certo rilievo sia spia di una velato, diffuso utilizzo di una somministrazione irregolare di massa, come accertato dalle plurime indagini della Procura di Milano. Provare a disinnescare tale realtà, per legge, vorrebbe dire provare a rendere lecite condotte che tali non sono.
Rivendichiamo:
- La necessità di una totale, netta autonomia tra attività del committente e quella dell’appaltatore;
- La necessità di un’autentica indipendenza, sul piano sia operativo che decisionale, da parte degli appaltatori (al di là della mera questione organizzativa di ferie, turni, ecc).
Infatti si è verificata negli ultimi anni una smisurata proliferazione di una costellazione di “imprese” che sovente sono tali solo sulla carta, prive di reale consistenza patrimoniale.
Riteniamo che il principale meccanismo di controllo effettivo dell’immissione nel mercato di aziende virtuose passa per l’effettiva consistenza patrimoniale in capo ai soggetti appaltatori, in quanto la prassi insegna che è proprio l’inconsistenza patrimoniale di tali soggetti a generare distorsioni, mancate retribuzioni, diffusi sotto- inquadramenti o violazioni di legge in materia di lavoro precari e che tale circostanza favorisca (essendo al contempo causa e conseguenza) dei sistematici, diffusi “cambi appalto” sovente a danno, non solo dei lavoratori, ma anche della fiscalità collettiva.
Insistiamo per l’introduzione di meccanismi che impongano agli appaltatori la proprietà dei mezzi di produzione, come già previsto dalla legge 1369/60, vigente per oltre 40 anni, secondo cui: art.1 comma 3 “é considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante”.
Quanto al vincolo di solidarietà, rivendichiamo che trattasi di questione non negoziabile poiché rappresenta uno dei pochi meccanismi che garantisce un coinvolgimento reale del committente nell’attività di controllo dei fornitori;
Sarebbe opportuno abrogare la norma che prevede e limita la possibilità di agire in solidarietà con il limite di 2 anni dalla fine dell’appalto.
Testo proposto Art. 29 Appalto
- Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa sempre che l’appaltatore possegga
una struttura imprenditoriale in grado di garantire un risultato produttivo autonomo.
- E’ considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine, dispositivi o attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante”
((1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto))
- In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 5 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
- L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti rilevanti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
*
-
- MODIFICHE ORGANIZZATIVE
In buona sostanza, si pretende ampliare l’elenco di materie oggetto di contratti di prossimità, attualmente tassativamente elencato nell’art.8 l.148/11.
I contratti di prossimità, lunghi dall’essere serviti a garantire effettivi elementi di flessibilità, sono stati utilizzati a discapito degli interessi dei lavoratori, sovente attraverso accordi presi per il tramite di oo.ss prive di reale rappresentatività presso le singole unità aziendali.
Per cui tale veicolo negoziale risulta di – molto – dubbia efficacia (esempio: accordi sulla malattia, su sotto/inquadramenti, su estensione del periodo di lavoro precario, sui limiti di contingentamento) perché nella prassi sono sempre a discapito degli interessi dei lavoratori.
Per cui:
- Intanto è sempre più urgente trovare un metodo realistico di misurazione della rappresentatività, affinché le o.s. eventualmente firmatarie siano veramente a conoscenza delle dinamiche interne delle società.
- Secondariamente, vanno comunque preferiti strumenti diversi (gli stessi ccnl, ad esempio o comunque accordi settoriali preferibilmente di carattere nazionali);
- In terzo luogo, va garantito un meccanismo trasparente che consenta ai lavoratori di poter/dover personalmente avallare tali accordi, tramite referendum o meccanismi analogo nonché, a quelli dissenzienti, di potersi sganciare da accordi che non siano da questi condivisi.
- Quanto alla flessibilità devono assolutamente essere inserite clausole di precedenza in favore del personale inizialmente assunto con contratti precari che serva a garantire un percorso di pressoché certa stabilità, anche non immediata, in modo da prevenire gli abusi.
- L’apprendistato deve rimanere una figura residuale, le scuole devono essere spazi in cui vengono formate le persone a livello pedagogico, scientifico, politico, artistico, economico, sociale che devono essere fuori dal perimetro dell’interesse aziendale. La scuola deve servire a formare persone, non lavoratori. Tale compito spetta poi alle imprese, in via assolutamente esclusiva, caricandosi dei relativi oneri.
D. LAVORO AGILE
- Riteniamo che sia essenziale garantire meccanismi trasparenti di disconnessione, con annesse sanzioni in caso di violazione, nonché – più in generale, dunque non solo per i lavoratori a distanza – di garantire tempi congrui di preavviso in ipotesi di spostamento turno, comunicazione d’inizio della prestazione, ecc. soprattutto per le lavoratrici ed i lavoratori impiegati con contratti di lavoro p.time.
A cura di
Usb Lavoro Privato Settore Logistica, 25.8.2025
Massimo Pedretti Esecutivo Nazionale Usb Lavoro Privato
Avv. Jacobo Sanchez Codoni CeIng – Centro di Iniziativa Giuridica Abd El Salam